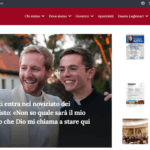Cari fratelli e sorelle:
Lo scorso anno abbiamo riflettuto sulla necessità di “andare e vedere” per scoprire la realtà e poterla raccontare a partire dall’esperienza degli avvenimenti e dell’incontro con le persone. Seguendo questa linea, desidero ora concentrare l’attenzione su un altro verbo, “ascoltare”, decisivo nella grammatica della comunicazione e condizione per un dialogo autentico.
In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo davanti, sia nella trama normale delle relazioni quotidiane, sia nei dibattiti sui temi più importanti della vita civile. Allo stesso tempo, l’ascolto sta vivendo un nuovo e importante sviluppo nel campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte di podcast e chat audio, il che conferma che ascoltare continua a essere essenziale per la comunicazione umana.
A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell’anima, chiesero qual era la maggiore necessità degli esseri umani. Rispose: “Il desiderio illimitato di essere ascoltati”. È un desiderio che spesso rimane nascosto, ma che interpella tutti coloro che sono chiamati a essere educatori o formatori, o che svolgono un ruolo di comunicatore: genitori e insegnanti, pastori e agenti di pastorale, operatori dell’informazione e quanti prestano un servizio sociale o politico.
Ascoltare con le orecchie del cuore
Nelle pagine bibliche apprendiamo che l’ascolto non possiede solo il significato di una percezione acustica, ma è essenzialmente legato alla relazione dialogica tra Dio e l’umanità. «Shema’ Israel – Ascolta, Israele» (Dt 6,4), l’incipit del primo comandamento della Torah si ripropone continuamente nella Bibbia, fino al punto che san Paolo afferma che «la fede proviene dall’ascolto» (Rm 10,17). Efficacemente, l’iniziativa è di Dio che ci parla, e noi rispondiamo ascoltandolo; ma anche questa ascolto, in fondo, proviene dalla sua grazia, come avviene al neonato che risponde allo sguardo e alla voce della mamma e del papà. Dei cinque sensi, sembra che il privilegiato da Dio sia proprio l’orecchio, forse perché è meno invasivo, più discreto della vista, e quindi lascia l’essere umano più libero.
L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a sua immagine, e, ascoltando, lo riconosce come suo interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la Parola, per questo “inclina l’orecchio” per ascoltarlo.
L’uomo, al contrario, tende a fuggire dalla relazione, a voltare le spalle e “chiudere le orecchie” per non dover ascoltare. Il rifiuto di ascoltare si trasforma spesso in aggressività verso l’altro, come accadde agli ascoltatori del diacono Stefano, che, tappandosi le orecchie, si lanciarono tutti insieme contro di lui (cf. At 7,57).
Così, da una parte c’è Dio, che si rivela sempre comunicando gratuitamente; e dall’altra, l’uomo, a cui si chiede di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l’uomo a un’alleanza d’amore, affinché possa arrivare a essere pienamente ciò che è: immagine e somiglianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di accogliere, di dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è una dimensione dell’amore.
Per questo Gesù chiede ai suoi discepoli di verificare la qualità del loro ascolto: «Prestate attenzione a come ascoltate» (Lc 8,18); li esorta in questo modo dopo aver raccontato loro la parabola del seminatore, lasciando intendere che non basta ascoltare, ma bisogna farlo bene. Solo dà frutti di vita e di salvezza chi accoglie la Parola con il cuore “ben disposto e buono” e la custodisce fedelmente (cf. Lc 8,15). Solo prestando attenzione a chi ascoltiamo, cosa ascoltiamo e come ascoltiamo possiamo crescere nell’arte di comunicare, il cui centro non è una teoria o una tecnica, ma la «capacità del cuore che rende possibile la prossimità» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 171).
Tutti abbiamo orecchi, ma molte volte anche chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare gli altri. Esiste davvero una sordità interiore peggiore della sordità fisica. L’ascolto, infatti, non ha a che vedere solamente con il senso dell’udito, ma con tutta la persona. La vera sede dell’ascolto è il cuore. Il re Salomone, nonostante fosse molto giovane, dimostrò saggezza perché chiese al Signore di concedergli «un cuore capace di ascoltare» ( 1 Re 3,9). E san Agostino invitava ad ascoltare con il cuore ( corde audire), ad accogliere le parole non esteriormente negli orecchi, ma spiritualmente nel cuore: «Non abbiate il cuore negli orecchi, ma gli orecchi nel cuore» [1]. E san Francesco d’Assisi esortava i suoi fratelli a «inclinare l’orecchio del cuore» [2].
La prima ascolto che bisogna riscoprire quando si cerca una comunicazione vera è l’ascolto di sé stessi, delle proprie esigenze più vere, quelle che sono inscritte nell’intimo di ogni persona. E non possiamo che ascoltare ciò che ci rende unici nella creazione: il desiderio di essere in relazione con gli altri e con l’Altro. Non siamo fatti per vivere come atomi, ma insieme.
L’ascolto come condizione della buona comunicazione
Esiste un uso dell’orecchio che non è vero ascolto, ma il contrario: ascoltare di nascosto. Di fatto, una tentazione sempre presente e che oggi, nel tempo dei social network, sembra essersi acuita, è quella di ascoltare di nascosto e spiare, strumentalizzando gli altri per il nostro interesse. Al contrario, ciò che rende buona e pienamente umana la comunicazione è proprio l’ascolto di chi abbiamo davanti, faccia a faccia, l’ascolto dell’altro a cui ci avviciniamo con apertura leale, fiduciosa e onesta.
Purtroppo, la mancanza di ascolto, che sperimentiamo molte volte nella vita quotidiana, è evidente anche nella vita pubblica, in cui, spesso, invece di ascoltare l’altro, ciò che ci piace è ascoltarci da soli. Questo è un segno che, più che la verità e il bene, si cerca il consenso; più che all’ascolto, si è attenti all’audience. La buona comunicazione, invece, non mira a impressionare il pubblico con un commento arguto volto a ridicolizzare l’interlocutore, ma presta attenzione alle ragioni dell’altro e cerca di far comprendere la complessità della realtà. È triste quando, anche in Chiesa, si formano schieramenti ideologici, scompare l’ascolto e al suo posto si occupano contrapposizioni sterili.
In realtà, in molti dei nostri dialoghi non ci comunichiamo affatto. Semplicemente aspettiamo che l’altro finisca di parlare per imporre il nostro punto di vista. In queste situazioni, come segnala il filosofo Abraham Kaplan [3], il dialogo è un “duálogo”, un monologo a due voci. Nella vera comunicazione, invece, sia il tu che il io sono “in uscita”, tendono l’uno verso l’altro.
Ascoltare è, quindi, il primo e indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Non si comunica se prima non si è ascoltato, e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire un’informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo. Per raccontare un evento o descrivere una realtà in un reportage è essenziale aver saputo ascoltare, disposti anche a cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di partenza.
Efficacemente, solo uscendo dal monologo si può arrivare a quella concordanza di voci che è garanzia di una vera comunicazione. Ascoltare fonti diverse, “non accontentarsi di ciò che si trova per primo” —come insegnano gli esperti professionisti— garantisce affidabilità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. Ascoltare più voci, ascoltarsi reciprocamente, anche in Chiesa, tra fratelli e sorelle, ci permette di esercitare l’arte del discernimento, che appare sempre come la capacità di orientarsi in mezzo a una sinfonia di voci.
Ma, perché affrontare lo sforzo che richiede l’ascolto? Un grande diplomatico della Santa Sede, il cardinale Agostino Casaroli, parlava del “martirio della pazienza”, necessario per ascoltare e farsi ascoltare nelle negoziazioni con gli interlocutori più difficili, al fine di ottenere il massimo bene possibile in condizioni di limitazione della libertà. Ma anche in situazioni meno difficili, l’ascolto richiede sempre la virtù della pazienza, insieme alla capacità di lasciarsi sorprendere dalla verità — anche se solo un frammento della verità — della persona che stiamo ascoltando. Solo l’ammirazione permette la conoscenza. Mi riferisco alla curiosità infinita del bambino che guarda il mondo che lo circonda con gli occhi molto aperti. Ascoltare con questa disposizione d’animo —l’ammirazione del bambino con la coscienza di un adulto— è un arricchimento, perché ci sarà sempre qualcosa, anche minima, che posso imparare dall’altro e applicare alla mia vita.
La capacità di ascoltare la società è estremamente preziosa in questo tempo ferito dalla lunga pandemia. Molta sfiducia accumulata precedentemente verso l’“informazione ufficiale” ha causato una “infodemia”, all’interno della quale è sempre più difficile rendere credibile e trasparente il mondo dell’informazione. È necessario predisporre l’orecchio e ascoltare in profondità, soprattutto il malessere sociale aumentato dalla diminuzione o dalla cessazione di molte attività economiche.
Anche la realtà delle migrazioni forzate è un problema complesso, e nessuno ha la ricetta pronta per risolverlo. Ripeto che, per superare i pregiudizi sui migranti e ammorbidire la durezza dei nostri cuori, sarebbe necessario cercare di ascoltare le loro storie, dare un nome e una storia a ciascuno di loro. Molti bravi giornalisti già lo fanno. E molti altri lo farebbero se potessero. Incoraggiamoli! Ascoltiamo queste storie! Poi, ognuno sarà libero di sostenere le politiche migratorie che ritiene più adeguate per il proprio paese. Ma, in ogni caso, davanti ai nostri occhi non avremo più numeri o invasori pericolosi, ma volti e storie di persone concrete, sguardi, speranze, sofferenze di uomini e donne che bisogna ascoltare.
Ascoltarsi nella Chiesa
Anche nella Chiesa c’è molta necessità di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo offrirci gli uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell’ascolto ci è stato affidato da Colui che è l’ascoltatore per eccellenza, a cui siamo chiamati a partecipare. «Dobbiamo ascoltare con gli orecchi di Dio per poter parlare con la parola di Dio» [4]. Il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer ci ricorda in questo modo che il primo servizio che si deve prestare agli altri nella comunione consiste nell’ascoltarli. Chi non sa ascoltare il fratello, presto sarà incapace di ascoltare Dio [5].
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è “l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare prima di parlare, come esorta l’apostolo Giacomo: «Sia pronto ciascuno ad ascoltare, ma lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po’ del proprio tempo per ascoltare le persone è il primo gesto di carità.
Da poco è iniziato un cammino sinodale. Preghiamo affinché sia una grande occasione di ascolto reciproco. La comunione non è il risultato di strategie e programmi, ma si costruisce nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorelle. Come in un coro, l’unità non richiede uniformità, monotonia, ma pluralità e varietà di voci, polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione all’armonia dell’insieme. Questa armonia è stata ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte e ciascuna delle voci.
Consapevoli di partecipare a una comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, in cui ognuno può cantare con la propria voce accogliendo quelle degli altri come un dono, per manifestare l’armonia dell’insieme che lo Spirito Santo compone.
Roma, San Giovanni in Laterano, 24 gennaio 2022, Memoria di san Francesco di Sales.
Francesco
___________________________
[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» (Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 568). [2] Carta a tutta l’Ordine: Fonti Francescane, 216. [3] Cfr. La vita del dialogo, a cura di J. D. Roslansky, Communication. A discussion at the Nobel Conference, North-Holland Publishing Company – Amsterdam 1969, 89-108. [4] D. Bonhoeffer, Vita in comunità, Sígueme, Salamanca 2003, 92. [5] Cfr. ibíd., 90-91.