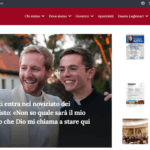Il Santo Padre ci invita a considerare, in questo tempo di preghiera, che “l’amore per Dio e per il prossimo è un unico amore”.
Cari fratelli e sorelle:
Quando il nostro Dio si rivela, comunica la libertà: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall’Egitto, da un luogo di schiavitù» (Es 20,2). Così si apre il Decalogo dato a Mosè sul monte Sinai. Il popolo sa bene di quale esodo parli Dio; l’esperienza di schiavitù è ancora impressa nella sua carne. Riceve le dieci parole dell’alleanza nel deserto come cammino verso la libertà. Noi le chiamiamo “comandamenti”, sottolineando la forza dell’amore con cui Dio educa il suo popolo. La chiamata alla libertà è, infatti, una chiamata vigorosa. Non si esaurisce in un evento unico, perché matura lungo il cammino.
Proprio come Israele nel deserto porta ancora dentro di sé l’Egitto — infatti, spesso rimpiange il passato e mormora contro il cielo e contro Mosè —, anche oggi il popolo di Dio porta dentro di sé catene oppressivi che deve decidere di abbandonare. Ce ne rendiamo conto quando ci manca la speranza e vaghiamo per la vita come in un deserto desolato, senza una terra promessa verso cui incamminarci insieme.
La Quaresima è il tempo di grazia in cui il deserto torna ad essere — come annuncia il profeta Osea — il luogo del primo amore (cf. Os 2,16-17). Dio educa il suo popolo affinché abbandoni le sue schiavitù e sperimenti il passaggio dalla morte alla vita. Come un sposo ci attira di nuovo a sé e sussurra parole d’amore ai nostri cuori.
L’esodo dalla schiavitù alla libertà non è un cammino astratto. Per rendere concreta anche la nostra Quaresima, il primo passo è voler vedere la realtà. Quando nel roveto ardente il Signore attirò Mosè e gli parlò, si rivelò immediatamente come un Dio che vede e soprattutto ascolta: «Ho visto l’oppressione del mio popolo, che è in Egitto, e ho udito i loro gridi di dolore, provocati dai loro capi» (Es 3,7-8). Anche oggi si ode al cielo il grido di tanti fratelli e sorelle oppressi. Domandiamoci: anche a noi arriva? Ci scuote? Ci commuove? Molti fattori ci allontanano gli uni dagli altri, negando la fraternità che ci unisce fin dall’origine.
Nel mio viaggio a Lampedusa, di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza ho posto due domande, sempre più attuali: «Dove sei?» (Gn 3,9) e «Dove è tuo fratello?» (Gn 4,9). Il cammino quaresimale sarà concreto se, riascoltandole, confessiamo di essere ancora sotto il dominio del Faraone. È un dominio che ci lascia esausti e ci rende insensibili.
È un modello di crescita che ci divide e ci ruba il futuro; che ha inquinato la terra, l’aria e l’acqua, ma anche le anime. Perché, sebbene con il battesimo sia iniziata la nostra liberazione, rimane in noi un’inesplicabile nostalgia per la schiavitù. È come un’attrazione verso la sicurezza di ciò che è già visto, a discapito della libertà.
Vorrei segnalare un dettaglio non di poca importanza nel racconto dell’Esodo: è Dio che vede, che si commuove e che libera, non è Israele che lo chiede. Il Faraone, infatti, distrugge anche i sogni, ruba il cielo, fa sembrare inamovibile un mondo in cui si calpesta la dignità e si negano i legami autentici.
Cioè, riesce a mantenere tutto soggetto a sé. Domandiamoci: desidero un mondo nuovo? Sono disposto a rompere gli impegni con il vecchio? La testimonianza di molti fratelli vescovi e di un gran numero di coloro che lavorano per la pace e la giustizia mi convince sempre più che ciò che bisogna denunciare è un deficit di speranza. È un ostacolo a sognare, un grido muto che arriva fino al cielo e commuove il cuore di Dio.
Ricorda quella nostalgia per la schiavitù che paralizza Israele nel deserto, impedendogli di avanzare. L’esodo può essere interrotto. Altrimenti non si spiegherebbe come un’umanità che ha raggiunto la soglia della fraternità universale e livelli di sviluppo scientifico, tecnico, culturale e giuridico, capaci di garantire la dignità di tutti, cammini nell’oscurità delle disuguaglianze e dei conflitti.
Dio non si stanca di noi. Accogliamo la Quaresima come il tempo forte in cui la sua Parola si rivolge di nuovo a noi: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall’Egitto, da un luogo di schiavitù» (Es 20,2). È tempo di conversione, tempo di libertà. Lo stesso Gesù, come ricordiamo ogni anno nella prima domenica di Quaresima, fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato nella sua libertà.
Per quarant’anni sarà davanti a noi e con noi: è il Figlio incarnato. A differenza del Faraone, Dio non vuole sudditi, ma figli. Il deserto è lo spazio in cui la nostra libertà può maturare in una decisione personale di non ricadere più nella schiavitù. In Quaresima, troviamo nuovi criteri di giudizio e una comunità con cui intraprendere un cammino che mai avevamo percorso prima.
Ciò comporta una lotta, che il libro dell’Esodo e le tentazioni di Gesù nel deserto ci narrano chiaramente. Alla voce di Dio, che dice: «Tu sei il mio Figlio molto amato» (Mc 1,11) e «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,3), si oppongono di fatto le menzogne del nemico. Più temibili del Faraone sono gli idoli; potremmo considerarli come la sua voce in noi. Sentirsi onnipotenti, riconosciuti da tutti, approfittare degli altri: ogni essere umano sente nel suo cuore la seduzione di questa menzogna. È un cammino già battuto.
Per questo, possiamo attaccarci al denaro, a certi progetti, idee, obiettivi, alla nostra posizione, a una tradizione e anche ad alcune persone. Quelle cose invece di spingerci, ci paralizzeranno. Invece di unirci, ci contrasteranno. Esiste, tuttavia, una nuova umanità, quella dei piccoli e umili che non sono caduti nell’incanto della menzogna. Mentre gli idoli diventano muti, ciechi, sordi, immobili a chi li serve (cf. Sal 115,8), i poveri di spirito sono immediatamente aperti e ben disposti; sono una forza silenziosa del bene che sana e sostiene il mondo.
È tempo di agire, e in Quaresima agire significa anche fermarsi. Fermarsi in preghiera, per accogliere la Parola di Dio, e fermarsi come il samaritano, davanti al fratello ferito. L’amore per Dio e per il prossimo è un unico amore. Non avere altri dèi significa fermarsi davanti alla presenza di Dio, nella carne del prossimo. Per questo la preghiera, la carità e il digiuno non sono tre esercizi indipendenti, ma un unico movimento di apertura, di svuotamento: fuori gli idoli che ci opprimono, fuori gli attaccamenti che ci imprigionano. Allora il cuore atrofizzato e isolato si risveglierà.
Perciò, rallentare e fermarsi. La dimensione contemplativa della vita, che la Quaresima ci farà riscoprire, mobiliterà nuove energie. Davanti alla presenza di Dio ci convertiamo in sorelle e fratelli, percepiamo gli altri con nuova intensità; invece di minacce e nemici troviamo compagni di viaggio. Questo è il sogno di Dio, la terra promessa verso cui camminiamo quando usciamo dalla schiavitù.
La forma sinodale della Chiesa, che in questi ultimi anni stiamo riscoprendo e coltivando, suggerisce che la Quaresima sia anche un tempo di decisioni comunitarie, di piccole e grandi decisioni a contracorrente, capaci di cambiare la quotidianità delle persone e la vita di un quartiere: le abitudini di acquisto, la cura della creazione, l’inclusione degli invisibili o degli emarginati. Invito tutte le comunità cristiane a fare questo: a offrire ai propri fedeli momenti di riflessione sugli stili di vita; a prendersi del tempo per verificare la loro presenza nel quartiere e il loro contributo per migliorarlo.
Guai a noi se la penitenza cristiana fosse come quella che addolorava Gesù. Anche a noi Egli dice: «Non mettete facce tristi, come fanno gli ipocriti, che alterano il volto per far vedere che digiunano» (Mt 6,16). Piuttosto, che si veda la gioia sui volti, che si percepisca il profumo della libertà, che si liberi quell’amore che rinnova ogni cosa, a cominciare dalle più piccole e vicine. Questo può succedere in ogni comunità cristiana.
Nella misura in cui questa Quaresima sarà di conversione, allora, l’umanità smarrita sentirà un fremito di creatività; lo scintillio di una nuova speranza. Vorrei dirvi, come ai giovani che ho incontrato a Lisbona lo scorso estate: «Cercate e rischiate, cercate e rischiate.
In questo momento storico le sfide sono enormi, i gemiti dolorosi — stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi —, ma abbracciamo il rischio di pensare che non siamo in agonia, ma in un parto; non alla fine, ma all’inizio di uno spettacolo grandioso. E ci vuole coraggio per pensarlo» ( Discorso ai universitari, 3 agosto 2023). È il coraggio della conversione, di uscire dalla schiavitù. La fede e la carità portano di mano questa piccola speranza. Le insegnano a camminare e, allo stesso tempo, sono esse a trascinarle avanti.
Li benedico tutti e il vostro cammino quaresimale.
Roma, San Giovanni in Laterano, 3 dicembre 2023, I Domenica di Avvento.
Immagine: Cathopic