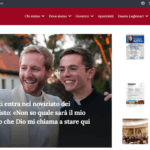Omelia di Papa Francesco a
sacerdoti, seminaristi, religiosi e religiose
Morelia, 16 febbraio 2016
C’è un detto che dice così: «Dimmi come preghi e ti dirò come vivi, dimmi come vivi e ti dirò come preghi», perché mostrandomi come preghi, imparerò a scoprire il Dio che vivi e, mostrandomi come vivi, imparerò a credere nel Dio a cui preghi»; perché la nostra vita parla di preghiera e la preghiera parla della nostra vita; perché la nostra vita parla nella preghiera e la preghiera parla nella nostra vita. A pregare si impara, come impariamo a camminare, a parlare, ad ascoltare. La scuola della preghiera è la scuola della vita e nella scuola della vita è dove facciamo la scuola della preghiera.
Gesù volle introdurre i suoi nel mistero della Vita, nel mistero della sua vita. Gli mostrò mangiando, dormendo, curando, predicando, pregando, cosa significa essere Figlio di Dio. Li invitò a condividere la sua vita, la sua intimità e stando con Lui, li fece toccare con la carne la vita del Padre. Li fa sperimentare nel suo sguardo, nel suo cammino la forza, la novità di dire: «Padre nostro». In Gesù, questa espressione non ha il «gusto» della routine o della ripetizione, al contrario, ha sapore di vita, di esperienza, di autenticità. Egli seppe vivere pregando e pregare vivendo, dicendo: Padre nostro.
E ci ha invitato anche noi allo stesso. La nostra prima chiamata è a fare esperienza di quell’amore misericordioso del Padre nella nostra vita, nella nostra storia. La sua prima chiamata è a introdurci in questa nuova dinamica di amore, di filiazione. La nostra prima chiamata è imparare a dire «Padre nostro», a dire Abba.
¡Ahimè se non evangelizzassi!, dice Paolo. ¡Ahimè! perché evangelizzare — prosegue — non è motivo di gloria ma di necessità (cfr. 1 Cor 9,16).
Ci ha invitato a partecipare della sua vita, della vita divina, ahimè se non la condividiamo, ahimè se non siamo testimoni di ciò che abbiamo visto e udito, ahimè. Non siamo né vogliamo essere funzionari del divino, non siamo né vogliamo essere mai impiegati di Dio, perché siamo invitati a partecipare della sua vita, siamo invitati a introdurci nel suo cuore, un cuore che prega e vive dicendo: «Padre nostro». Cos’è la missione se non dire con la nostra vita: «Padre nostro»?
A questo Padre nostro è a cui preghiamo con insistenza ogni giorno: non ci lasciare cadere in tentazione. Lo stesso Gesù lo fece. Egli pregò affinché i suoi discepoli — di ieri e di oggi — non cadessimo in tentazione. Quale può essere una delle tentazioni che potrebbe assediarci? Quale può essere una delle tentazioni che nasce non solo dal contemplare la realtà ma dal camminarla?
Quale tentazione ci può venire da ambienti molte volte dominati dalla violenza, dalla corruzione, dal traffico di droga, dal disprezzo per la dignità della persona, dall’indifferenza davanti alla sofferenza e alla precarietà? Quale tentazione possiamo avere ancora e ancora di fronte a questa realtà che sembra essersi trasformata in un sistema immutabile?
Credo che potremmo riassumerla con la parola rassegnazione. Di fronte a questa realtà ci può vincere una delle armi preferite del demonio, la rassegnazione. Una rassegnazione che ci paralizza e ci impedisce non solo di camminare, ma anche di fare strada; una rassegnazione che non solo ci spaventa, ma ci arroccia nelle nostre «sacrestie» e apparenti sicurezze; una rassegnazione che non solo ci impedisce di annunciare, ma ci impedisce di lodare. Una rassegnazione che non solo ci impedisce di proiettare, ma ci impedisce di rischiare e di trasformare.
Perciò, Padre nostro, non ci lasciare cadere in tentazione. Quanto ci fa bene appellarci nei momenti di tentazione alla nostra memoria.
Quanto ci aiuta guardare il «legno» di cui siamo fatti. Non tutto è iniziato con noi, non tutto finirà con noi, perciò quanto ci fa bene recuperare la storia che ci ha portato fin qui.
E, in questo fare memoria, non possiamo saltare qualcuno che amò così tanto questo luogo da farsi figlio di questa terra. A qualcuno che seppe dire di sé stesso: «Mi hanno strappato dalla magistratura e mi hanno messo al timone del sacerdozio, per merito dei miei peccati. A me, inutile e completamente inadatto all’esecuzione di così grande impresa; a me, che non sapevo maneggiare il remo, hanno scelto come primo Vescovo di Michoacán» (Vasco Vázquez de Quiroga, Lettera pastorale, 1554).
Con voi voglio fare memoria di questo evangelizzatore, conosciuto anche come Tata Vasco, come «lo spagnolo che si fece indio». La realtà che vivevano gli indiani Purhépechas descritti da lui come «venduti, umiliati e vagabondi per i mercati, raccogliendo le briciole gettate per terra», lontano dal portarlo alla tentazione e alla amarezza della rassegnazione, mosse la sua fede, mosse la sua vita, mosse la sua compassione e lo spinse a fare diverse proposte che fossero di «respiro» davanti a questa realtà così paralizzante e ingiusta. Il dolore della sofferenza dei suoi fratelli divenne preghiera e la preghiera divenne risposta. Questo gli valse il nome tra gli indiani di «Tata Vasco», che in lingua purhépecha significa: Papà.
Padre, papà, abba.
Questa è la preghiera, questa è l’espressione a cui Gesù ci invitò.
Padre, papà, abba, non ci lasciare cadere in tentazione di rassegnazione, non ci lasciare cadere in tentazione di perdere la memoria, non ci lasciare cadere in tentazione di dimenticare i nostri anziani che ci hanno insegnato con la loro vita a dire: Padre Nostro.
Audio dell’omelia del Papa
Fonte: News.va