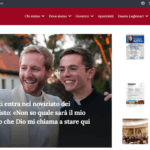Il padre Manuel Cevallos, LC ha difeso la sua tesi di dottorato il 30 novembre presso l’Istituto Orientale Pontificio. Il titolo della sua tesi è stato «Note sulla ecclesiologia maronita precedente al grande sinodo del 1736: studio a partire da alcuni documenti significativi del XVII secolo». «Questo sinodo è stato l’adattamento per i maroniti di tutto ciò che è stato stabilito a Trento; la tesi fa una ricostruzione storico-teologica della concezione ecclesiologica dei maroniti originaria a partire dallo studio e dall’edizione di documenti», ha commentato il padre Manuel.

«Ho deciso di affrontare questo tema perché dovevo specializzarmi in ecclesiologia in vista dell’insegnamento (da gennaio sarò professore di ecclesiologia presso il Istituto di Studi Superiori di Tamaulipas) e mi sembrava necessario conoscere l’ecclesiologia d’Oriente. Ho scelto i maroniti perché sono una delle due chiese cattoliche orientali che non hanno una controparte ortodossa e perché è la chiesa orientale più presente in Messico», ha detto il padre Manuel. «La pluralità della Chiesa nella sua fondamentale unità in Cristo è stata per me la chiave per iniziare a considerare l’Oriente Cristiano, e in particolare l’Oriente cristiano cattolico», ha aggiunto.
La tesi di dottorato del padre Manuel si divide in un’introduzione generale, una concettualizzazione storica, due parti e la conclusione. Il padre Manuel commentava durante la sua esposizione che «la prima parte della tesi consiste nell’edizione e traduzione in spagnolo dei gruppi di documenti d’archivio scelti per lo studio, ciascuno accompagnato da un’analisi propria degli aspetti che si vogliono mettere in evidenza durante lo studio». Ha commentato che i risultati di tale analisi si potevano riassumere in 5 punti: l’autorità totale o centralizzata del patriarca sui maroniti; l’esercizio dei munera episcopali del patriarca maronita secondo il suo patrimonio consuetudinario proprio; la non residenza degli episcopi maroniti nelle loro diocesi; la consapevolezza dei patriarchi maroniti di essere i legittimi patriarchi cattolici d’Oriente; la fedeltà dei maroniti all’unione con la sede di Roma che si manifestava e si viveva nella fedeltà alle proprie tradizioni. Il padre Manuel commentava che i documenti più significativi dello studio di questa prima parte furono il memoriale del patriarca Yūḥannā Maḫlūf, del 1625, e la lettera dell’arcipresbitero Giovanni Hesronita, anch’essa del 1625.

«La seconda parte della tesi, strutturata in quattro capitoli, offre una visione più globale dell’auto-comprensione ecclesiologica dei maroniti, analizzando nel complesso gli aspetti più rilevanti che emergono dall’analisi di ogni documento», ha detto il padre Manuel durante il suo intervento. «Il primo capitolo tratta della centralità dell’autorità patriarcale, elemento predominante nei contenuti dei documenti analizzati, sottolineando la necessità che aveva la comunità, sorta attorno al monastero di Beyt Marūn, di auto-procurarsi una figura che la comunità potesse riconoscere come suo rappresentante autorizzato, sia ad intra che ad extra […] Il secondo capitolo ha come asse la relazione tra il patriarca e gli episcopi, relazione che a sua volta ci rivela aspetti notevoli della struttura della Chiesa maronita […] Tenendo conto della struttura generale della Chiesa maronita prima del sinodo del 1736, il terzo e il quarto capitolo della seconda parte considerano il ruolo dei maroniti nella Chiesa cattolica», ha aggiunto il padre Manuel.
Ha anche commentato che durante il processo di ricerca la cosa più difficile è stata «integrare due metodologie molto diverse in un’unica ricerca: quella storico- esegetica (chiamata “storia della mentalità”) e quella teologica».

Il padre Manuel affermava che, come risposta e riepilogo della sua ricerca, si possono evidenziare i seguenti elementi: «il primo si può enunciare così: “il modo di essere Chiesa” dei maroniti corrisponde a una concezione, o più precisamente, a una matrice patriarcale monarchica […] Il patriarca ha la responsabilità di conservare e far rispettare il patrimonio consuetudinario della Chiesa perché questo identifica i maroniti come cattolici antiocheni; l’espressione di questa fede propio more manifesta anche la loro comunione con Roma. Per tutelare tale responsabilità nelle circostanze di vita specifiche dei maroniti, l’esercizio dell’autorità del patriarca era monarchico, cioè, autonomo e totalmente centralizzato; la collegialità si faceva presente solo nell’elezione del patriarca. Il secondo elemento è rappresentato dall’esperienza ecclesiale dei maroniti: si tratta di un’esperienza sui generis realizzata nel modo particolare dell’esercizio dei munera episcopali del patriarca che si riflette nella struttura interna della Chiesa maronita».
«Infine, speriamo che i tratti dell’ecclesiologia maronita precedente al sinodo del 1736 […] possano aprire le porte a nuove proposte per un’ecclesiologia maronita più completa e organica. Spero di aver contribuito a una migliore conoscenza di una Chiesa che per secoli ha dimostrato di essere, in mezzo alle prove e alle difficoltà, figlia fedele della tradizione antioquena e testimone di Cristo Signore», ha concluso il padre Manuel.